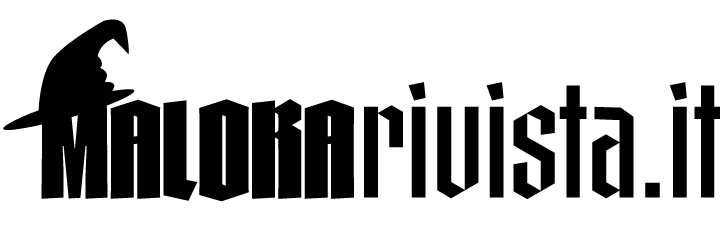Città Sommerse è il libro d’esordio della scrittrice torinese, Marta Barone, vincitrice del Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini.
Nel libro dici di aver scritto per un “atto di interesse”. Quando hai iniziato a immaginare questo libro e perché? Come è stata la sua gestazione?
“Ho scelto la parola interesse nel suo senso proprio di “interessamento a”: rivolgersi improvvisamente verso qualcosa e guardarlo, provare attenzione verso l’oggetto o, in questo caso, l’individuo. Negli Imperdonabili Cristina Campo scriveva che “l’attenzione è il solo cammino verso l’inesprimibile, la sola strada al mistero”, e che accettare di provare attenzione verso qualcosa significa accettare di soffrirla e soffrire per essa. Quest’accettazione, naturalmente, non è stata facile né breve, ha comportato una grande fatica (anche perché ero fissata su un altro libro da scrivere di tutt’altra natura, che però non prendeva mai forma) e quasi una violenza su me stessa, perché con mio padre ho avuto un rapporto complesso e spesso doloroso. Provavo una sensazione di rifiuto ma allo stesso tempo, man mano che si aggiungevano piccoli pezzi in quella primavera del 2014 che ora sembra eterna, la potenza della storia e del personaggio stesso, talmente sconosciuto da potersi quasi distaccare dall’uomo che conoscevo io, l’attrazione per quella storia aumentava, e alla fine mi sono ritrovata a un tavolo, quasi con rabbia, dico nel romanzo, a buttare giù le prime pagine sparse. Nel corso del tempo, poi, con gli altri incontri, le ricerche, le nuove scoperte, si è poi aggiunto tantissimo altro materiale che ho dovuto scegliere come gestire”.
Il libro si snoda tra due piani: quello personale della tua vicenda e della tua famiglia e quello sociale e comunitario della storia di un paese, della Storia intesa come studio del passato recuperato e ricostruito attraverso fonti e documenti che delineano a poco a poco, quasi a chiudere il cerchio, la vicenda affettiva tua e di tuo padre. Mentre svolgevi questa matassa cosa emergeva per prima e cosa ha fatto da traino ad altro?
“Ho deciso molto tardi come intrecciare i due piani, le immagini rapsodiche della mia infanzia, il mio percorso personale e artistico e il bizzarrissimo Bildungsroman di mio padre. Solo quando ho capito che c’era una seconda Kitež che stava emergendo (i lettori capiranno) mi sono resa conto che era quella la vera sottotrama. Quindi, mi sono trasformata anch’io in un mio personaggio, separato dalla mia voce presente: la giovane donna ostinata, fragilissima, ferita e piena di convinzioni ferree che ero anni prima. E proprio da questo tema sotterraneo sono ripartita: il vagare per Milano e le immagini che mi appaiono di fronte ma che non so come processare. Poi, nel corso della narrazione, proprio seguendo a tratti il filo della mia esistenza mostravo da piccoli indizi che mi erano ancora illeggibili, da piccole epifanie che faticavo ancora a inquadrare, ho raccontato anche quella parte: il passaggio da una cecità a una visione più ampia e diversa, un passaggio anche di scrittura. Dato che sapevo già esattamente tutto quello che volevo scrivere, ho fatto una serie di piccole schede con le parti separate, numerandole, ma ben sapendo che magari una “scena” (così le ho battezzate) avrebbe potuto essere spostata un po’ prima o un po’ dopo a seconda di necessità che sarebbero emerse solo durante la stesura. Non volevo fare un romanzo convenzionale e nemmeno una biografia, e questo intreccio di multipli piani temporali segue il ritmo che desideravo, un moto ondoso che va avanti e indietro nel tempo. Direi che le parti si facevano da traino a turno, soprattutto perché la riflessione sulla nostra non conoscenza dell’altro, e quindi le domande senza risposta sul ragazzo misterioso e affascinante che era L. B., portavano spesso a riflessioni su me stessa, sul tempo e sulla memoria. Non c’è una vera e propria separatezza, quindi, tra questi due piani, a parte in alcuni capitoli”.
La figura del padre viene ricostruita e riappropriata della figlia e dalla scrittrice, da chi per prima?
“Immediatamente, sin dal primo incontro con Agata e dal racconto dei fatti di via Artisti, dalla figlia”.
Come sei riuscita a sfuggire all’esercizio di ricostruzione geologica di questa figura genitoriale senza farla diventare mitologia?
“Non lo so. Forse perché le sue decisioni erano talmente strane, forse perché L. B. era perennemente in fuga ed era così arzigogolato e inafferrabile, forse perché le sue scelte politiche erano talvolta assurde, che persino la sua indubbia bontà e la sua aura, leggendarie per chi lo racconta, assumono meno pathos e prendono una realtà molto più corporea, molto più viva di un quadretto agiografico che non sarebbe servito a nessuno, e che non gli sarebbe somigliato per niente”.
 Il primo capitolo di Città sommersa si intitola “La prima Kitež”, la città che si inabissa nel lago per non essere espugnata. Da questa superficie che fa scomparire le cose tu hai riacciuffato la storia di tuo padre, moltiplicando il rumore e le parole attorno alla sua figura, andando a interrogare gli amici, i compagni di quegli anni: come hai fatto a mediare con la necessaria bugia che si incrosta sui ricordi che ricostruiscono il profilo di chi non c’è più?
Il primo capitolo di Città sommersa si intitola “La prima Kitež”, la città che si inabissa nel lago per non essere espugnata. Da questa superficie che fa scomparire le cose tu hai riacciuffato la storia di tuo padre, moltiplicando il rumore e le parole attorno alla sua figura, andando a interrogare gli amici, i compagni di quegli anni: come hai fatto a mediare con la necessaria bugia che si incrosta sui ricordi che ricostruiscono il profilo di chi non c’è più?“Ho dovuto scendere a patti con tante cose. Ci sono così tanti buchi che non verranno mai riempiti che il compromesso con i ricordi troppo lontani per essere veramente precisi o con la volubilità della memoria, non necessariamente menzogna ma di certo non sempre fatto, è stato necessario – dolorosissimo dal punto di vista umano, ma necessario. Eppure mi scrivono “lui era proprio così!”, e allora qualcosa forse dalla maglia strettissima straziante del setaccio del tempo deve essere passato, e rimarrà. Dal punto di vista romanzesco, ha una sua bellezza letteraria che il personaggio L. B. resti vagamente astratto, che conservi una sorta di magia della distanza”.
Nel corso del libro si assiste al tentativo di ricollocare e raccontare la vicenda di Servire il Popolo, l’ideologia e gli ideali di comunanza, di attivismo. Che idea ti sei fatta di quella esperienza politica attraverso i tuoi occhi e la tua “noiosa storia personale di raznočinec occidentale nata alla fine del Ventesimo secolo, nella pace, nel benessere, nell’affetto, nella disponibilità culturale”?
“Non commenterò per l’ennesima volta gli aspetti ridicoli, dolorosi, settari e spesso anche con conseguenze orribili dell’Unione dei marxisti-leninisti. Mi interessa molto di più, pur se nel caso di mio padre e di molti suoi amici (ma non tutti, altri facevano parte di altre formazioni politiche, e questo costituiva una parte della sua libertà interiore che irritava molto il Partito), proprio quell’idea di comunanza, chiamiamola anche comunione, di vita insieme spesso totalizzante che adesso probabilmente non saremmo più in grado di fare, l’idea di pratica e di sacrificio per l’altro, per gli altri, per i più deboli. Loro stessi lo dicono: quel mondo non esiste più, non sarà più possibile rifarlo in quella forma, perché non esiste più il mito, l’ideologia, la spinta verso un avvenire radioso che è stato schiacciato, cancellato e massacrato dallo Stato e anche da chi ha deciso che assassinare era la via più semplice. Eppure il semplice fatto che quel mondo ci sia stato, che quegli uomini e quelle donne abbiano fatto ciò che hanno fatto e spesso continuino ancora a fare, in una dimensione più piccola e privata, ma sempre rivolta all’altro, alla memoria e alla storia, lascia un seme fondamentale di speranza. Io ho fatto le mie esperienze politiche e continuo a farle al di fuori del lavoro artistico, ma so bene che restiamo monadi e che sarà difficile per chi verrà più tardi lottare in un mondo che sembra votato alla distruzione. Ma lascio quel “sembra”: io ho speranza. Ho speranza”.
Le parole che usi sono letterarie e dense, precise, creatrici di immagini vivide e denotano un lavoro puntuale di limatura, nonostante si applichino ad una materia che spesso si fa nell’assenza, nella ricostruzione di ricordi sbiaditi. È stata una scelta precisa? Come è stato il lavoro di scrittura?
“Il lavoro di scrittura è stato difficilissimo, proprio perché volevo una lingua letteraria e ricca che provenisse dai miei riferimenti letterari, da Nabokov a Ortese a Bachmann a Yourcenar e molti altri ancora, volevo una lingua che fosse assolutamente avulsa dal “classico romanzo sugli anni settanta” perché desideravo che il libro fosse letto in un certo modo, che fosse un romanzo su un personaggio metà immaginato, sul dolore l’amore la morte la vita e il funzionamento della memoria, anche se è pieno di episodi storici, che ho cercato nei limiti del possibile di sventrare e rendere personali. Rendere letterario ciò che è sempre stato giornalistico o saggistico, come la cronaca della Torino in disfacimento alla fine degli anni Settanta. Ho scritto e riscritto una pagina per settimane intere, finché non mi sembrava somigliasse vagamente a ciò che volevo (non siamo mai, mai soddisfatti). Volevo che ci fosse poesia, che ci fosse lirismo, che ci fossero immagini forti e originali, i sentimenti più nascosti degli umani. Paradossalmente una delle parti più difficili da scrivere è stata quella del rapporto con mio padre, che dovevo inserire perché il lettore capisse come mai il nostro amore era così pieno di rabbia e rancore e rimorso. Ogni volta mi sembrava di entrare in una caverna terrificante, ogni volta tagliavo qualcosa, ogni volta aggiungevo un dettaglio e poi lo spazzavo via. Molto più bello e dolce, e anche più facile, è stato scrivere del ragazzo immaginato, quel ragazzo meraviglioso di cui tutti si innamoravano, il ragazzo prima del carcere, prima dello “scarto” di cui parla Agata. Ed è a lui, non a caso, che è dedicato il libro”.